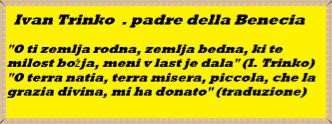La conserva del pomodoro

La gubana «al momento è totalmente priva di valorizzazione e ancor più di tutela. Ho riscontrato la nascita di nuovi produttori di gubane nel Pordenonese e addirittura in Veneto. Tutto ciò è molto preoccupante per le Valli del Natisone e il Cividalese, bacino originario di produzione»: è netto il giudizio di Jessica Dorbolò, titolare dell’omonima azienda produttrice di gubane, con sede a San Pietro al Natisone. La recente iniziativa di Slow Food, che vorrebbe aprire uno dei suoi presidi di tutela proprio per la gubana, viene vista come positiva. Anche se non ha una valenza normativa (è una azione privata che consente ai produttori che seguono il disciplinare che verrà eventualmente adottato da Slow Food, di apporre sui loro prodotti il marchio dell’associazione e di partecipare alla sue iniziative, in primis il Salone del gusto), potrebbe essere un importante stimolo per rimettere attorno ad un tavolo tutti i produttori per far ripartire un ragionamento sulla tutela e valorizzazione del dolce tipico della Slavia Friulana.
«La nascita di un presidio Slowfood sarebbe molto importante, visto che in passato non si è riusciti a fare nulla per la tutela della gubana – prosegue Jessica Dorbolò–. Non è stato possibile mettersi d’accordo sulla quantità di ingredienti che devono essere inseriti nella ricetta. In particolare il problema è sulla frutta secca, che incide molto sul costo, e ha diviso le produzioni di carattere artigianale da quelle più rivolte a fare grandi quantità per la grande distribuzione. Ma per realizzare un disciplinare comune e magari ottenere una tutela riconosciuta dell’Unione Europea c’è anche il problema che in loco non si riescono più a reperire tutti gli ingredienti, per i quantitativi che servono alle imprese produttrici. Ad esempio, mancano in tutta le regione produttori di noci, i primi si trovano in Veneto. Per le nocciole bisogna andare nella Bassa Friulana».
Ottenere una tutela Igp o Dop potrebbe portare concreti vantaggi ai produttori e al territorio? «Ritengo di sì – risponde Jessica Dorbolò – sia per ampliare il bacino di vendita della gubana oltre ai confini del Friuli che per valorizzarla in loco tra i turisti che vengono in Friuli Venezia Giulia. È evidente a tutti che i vini del Collio o il prosciutto di San Daniele hanno una notorietà e una attenzione molto maggiori, grazie anche e soprattutto alle denominazioni di origine che hanno ottenuto. Se il treno non è già passato, visto che in tanti si sono ap-propriati del nome gubana, sarebbe davvero importante farequalcosa per la tutela subito, trovando una formula che possa andare bene a tutti i produttori. Credo che sarebbe fondamentale l’iniziativa di una istituzione, penso ad esempio alla Comunità di Montagna Torre Natisone, visto che si tratta di difendere un bene culturale e non solo materiale dell’intero territorio e che avrebbe sicuramente l’autorevolezza per cercare di rimettere attorno ad un tavolo tutti i produttori».
Gubane Dorbolò ha fatto la scelta di puntare sulla vendita del dolce soprattutto attraverso i suoi due punti vendita, a San Pietro al Natisone e Cividale. Un altro importante canale, soprattutto fuori regione, è quello delle enoteche e dei negozi specializzati nella vendita di dolci e di prodotti tipici, non solo in Veneto ma anche a Roma, Milano e Torino. «Ultimamente abbiamo iniziato anche a vendere ad alcune realtà commerciali specializzate nel nord Europa, specie in Belgio e Lussemburgo. Funziona molto bene il connubio con i vini dolci e le grappe», spiega Jessica Dorbolò. Non c’è invece vendita significativa in Slovenia. Forse un mercato da esplorare di più da parte di tutti i produttori di gubana, visto che il dolce è già conosciuto in una buona porzione della regione del Litorale sloveno.
Da parte sua Mauro Vogrig, attuale amministratore dell’omonima ditta cividalese di gran lunga leader nel mercato del dolce tradizionale delle Valli del Natisone, considera «positiva ogni iniziativa che può favorire la diffusione geografica della gubana e il suo consumo frequente da parte del maggior numero di consumatori possibile. Dico invece un fermo “no” se si vogliono introdurre norme autoreferenziali, astratte, che non tengono conto della realtà produttiva e distributiva e che in nome della tutela e della valorizzazione in realtà costituiscono un ostacolo alla diffusione della gubana».
Intanto la «Giuditta Teresa» di Chiabai e Cattaneo di Azzida comunica di aver ottenuto il marchio «Io sono Friuli Venezia Giulia» e accompagna la notizia sulla propria pagina Facebook con una foto nella quale il proprio prodotto è significatamente presentato come «Gubanza». E proprio il nome autentico del dolce potrebbe essere una soluzione efficace per la sua tutela dalle dilaganti imitazioni. (Roberto Pensa)
Nella mitologia greca, il ciliegio era la pianta sacra a Venere e si pensava che i suoi frutti portassero fortuna agli innamorati. E in Sicilia? C’è la credenza che le dichiarazioni d’amore fatte all’ombra di un ciliegio siano fortunate, mentre in Inghilterra sognare un albero di ciliegie presagisce tanta fortuna e in Cina la ciliegia rappresenta la bellezza femminile.
La leggenda sassone, invece, racconta che gli alberi di ciliegio ospitino le divinità protettrici dei campi. Sempre in Oriente, e precisamente in Giappone, il fiore del ciliegio è un simbolo nazionale e viene data anche una spiegazione al colore rosa della sua inflorescenza: pare che in origine i fiori fossero bianchi, ma dopo una battaglia, alcuni samurai vennero sepolti proprio sotto a dei ciliegi. E i petali si tinsero così di rosa a causa del sangue versato dai valorosi guerrieri. dal web
Mia mamma faceva lo strudel di ciliegie du cui ero golosissima.
per la ricetta leggi qui https://blog.giallozafferano.it/cucinaconnene/strudel-di-ciliegie/
Buon appetito!
«È stata un’annata strana, capricciosa come il meteo – spiega Chiabai – ma alla fine abbiamo schivato il grosso problema delle grandinate e nei settori dell’orticoltura, frutticoltura, seminativi e foraggi il bilancio è positivo. Anzi, le temperature miti e il clima ventilato di questi giorni stanno facendo molto bene alla raccolta delle mele, il settore in cui ci sono, tra San Pietro al Natisone e Pulfero, le aziende agricole più grandi e infrastrutturate. La raccolta è partita sotto la pioggia, nell’unica settimana di maltempo, ma ora il cambiamento climatico ci sorride».
E sorride pure alla raccolta delle castagne, quest’anno un po’ tardiva e appena agli esordi, ma che si annuncia di ottima qualità. «C’era qualche preoccupazione, ma l’andamento del meteo sta favorendo la maturazione e la caduta dei frutti – spiega Chiabai –. Potrebbe essere un’annata molto buona, sotto il profilo della quantità ma soprattutto della qualità».
Chiunque conosca le Valli del Natisone e del Torre le associa mentalmente alla castagna, anche se ormai questa coltura ha un peso e un’estensione irrilevante per le aziende agricole organizzate. «Il castagno, però, oltre che un simbolo storico per la rilevanza che ha avuto per la vita delle nostre popolazioni – spiega Chiabai – è anche l’emblema di quello che dovrebbe diventare la nostra agricoltura: non possiamo competere sul prezzo con le produzioni meccanizzate di altre zone, ma dobbiamo raggiungere il consumatore finale attento alla qualità e alla salubrità, anzi dobbiamo farlo venire a visitare i nostri borghi e i nostri boschi. Siamo l’unica zona in regione che può vantare ben 9 varietà di castagna e questo può rimanere un’ottima integrazione del reddito che si sposa anche alla manutenzione dell’ambiente e alla lotta all’avanzare del bosco, perché il castagno richiede spazi aperti, sole e aria». Grazie alla nostra straordinaria biodiversità siamo riusciti a contenere meglio che altrove il problema del cinipide galligeno del castagno, il parassita che ha fatto temere negli anni scorsi la scomparsa del castagno dai nostri boschi.
Tra gli agricoltori della Slavia cresce la consapevolezza che, per battere le incertezze del cambiamento climatico, bisogna investire sulla diversificazione.
«Il settore che meglio permette di farlo è quello dell’orticoltura. Si può infatti scegliere tra una grande varietà di colture, a partire da quelle autoctone – spiega Chiabai – e una grande varietà di trasformazioni, che permettono anche di destagionalizzare il prodotto, ad esempio con le conserve in agrodolce e sotto aceto. Si possono valorizzare le varietà locali, come ad esempio la zucca a pasta bianca tipica della Valli del Natisone con cui si fa la zuppa “malonova”, oppure le rape, che possono avere una molteplicità di trasformazioni. Questo è un modo anche per ridurre gli sprechi e per arrivare al consumatore finale, quello disposto a pagare di più per un prodotto buono e genuino, aumentando il valore aggiunto che rimane all’impresa agricola. Un discorso che si lega anche al turismo e alla valorizzazione del territorio.Mancano però trasformatori, cioè professionisti di questa arte di produrre conserve. Questo può essere uno spazio professionale anche per i giovani», spiega Chiabai.
Ottima anche la produzione autoctona di foraggio, dopo la crisi dello scorso anno. Una boccata d’ossigeno per gli allevatori che non hanno dovuto acquistare i foraggi altrove, e magari un incentivo anche per sfalciare qualche prato in più.
Sempre più in rete con la Slovenia Un altro bell’esempio di evoluzione positiva dell’agricoltura nella Slavia viene dall’allevamento. Se nel settore lattiero-caseario si segnala l’ascesa di ottime produzioni di qualità locali, in quello della carne un ottimo risultato ha avuto il progetto transfrontaliero Interreg Italia-Slovenia denominato «Farm eat», ovvero «mangia in fattoria». Ha permesso ad allevatori della Benecia e della valle dell’Isonzo di mettersi in rete realizzando un disciplinare di produzione di carne di qualità: solo bovini da pascolo, regole ferree sull’alimentazione tra cui l’assoluto no agli Ogm. Il tutto completato dal ruolo chiave assunto dal macello di Tolmino, che si è occupato del taglio e del confezionamento della carne per i piccoli produttori.
«Unendo le forze si è potuto scavalcare l’ostacolo dei forti investimenti che sarebbero stati necessari a ciascuna azienda per provvedere a macellazione e confezionamento delle carni – spiega Chiabai –. Il legame con la Slovenia è fondamentale, perché nella valle dell’Isonzo il settore agricolo è molto forte e organizzato. Anche in questo settore c’è spazio per i giovani. Mancano casari, macellai, norcini». (Roberto Pensa ) dal Dom
Per ridurre lo spreco alimentare e facilitare la comprensione della data di scadenza del cibo, la Commissione europea ha proposto di aggiungere la nuova etichetta “spesso buono oltre” al fianco del classico “da consumarsi preferibilmente entro”. Secondo l’esecutivo dell’Unione, oltre a contribuire a un minore impatto ambientale, il cambiamento consentirà di migliorare il processo decisionale dei consumatori.
In base alla bozza del provvedimento, secondo uno studio della Commissione, la maggior parte dei consumatori in Europa non comprende appieno la distinzione tra le etichette con la dicitura “da consumare entro” e quelle con scritto “da consumarsi preferibilmente entro”. Le due formule dell'etichetta di un alimento si riferiscono infatti a due indicatori diversi, relativi alla sicurezza e l’altro alla qualità.
La prima dicitura indica l'effettiva data di scadenza, che avverte il consumatore o la consumatrice della data entro cui consumare l’alimento è ancora sano e sicuro per gli esseri umani. Dopo questa data il prodotto può deperire, ammuffire o cominciare a decomporsi. Al contrario, la seconda etichetta indica invece il momento in cui in cui potrebbe verificarsi un cambiamento della qualità dell’alimento, che pur restando completamente sicuro e sano da consumare, potrebbe non presentare più le stesse caratteristiche organolettiche, gustative o nutrizionali.
L’intervento fa parte delle molte misure contenute all’interno del Green deal europeo, per ridurre l’impatto ambientale dell’Unione in tutti i settori. In particolare, secondo la Commissione, questa iniziativa potrebbe contribuire a ridurre lo scarto alimentare europeo che si aggira attorno alle 57 milioni di tonnellate annue, pari a 127 chili per abitante, con un costo di circa 130 milioni di euro l’anno.
La nuova dicitura rappresenta solo un primo passo di Bruxelles per combattere lo spreco alimentare. Entro la prossima estate, l’esecutivo presenterà la prima proposta per una modifica mirata della direttiva sui rifiuti, alla quale la Commissione ha già cominciato a lavorare coinvolgendo governi, cittadini e imprese nelle consultazioni che vanno avanti da circa un anno. L’obiettivo sottoscritto dall’unione e dai governi degli stati membri è quello di ridurre del 50% lo spreco alimentare europeo entro il 2030.
https://www.wired.it/article/etichetta-cibi-alimentari-europa-spesso-buono-oltre/
da vita nei campi
Il “bacalà” mantecato: un sontuoso “mangiar di magro”
Maggio risveglia i nidi, maggio risveglia i cuori; porta le ortiche e i fiori, i serpi e l’usignol. Schiamazzano i fanciulli in terra, e i...