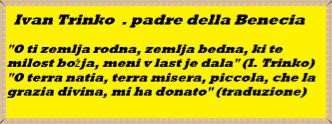Giambattista Tiepolo (o Giovanni Battista o Zuan Batista; Venezia, 5 marzo 1696 – Madrid, 27 marzo 1770) è stato un pittore e incisore italiano, cittadino della Repubblica di Venezia.[1] È il maggior pittore del Settecento veneziano.
Tra i suoi figli vi furono i pittori Giandomenico e Lorenzo Tiepolo.
È uno dei protagonisti della cultura figurativa europea del Settecento e la sua presenza a Udine, nella prima metà del secolo, fu determinante per lo sviluppo dell’arte in Friuli. Nato a Venezia il 5 marzo 1696, figlio di Domenico, capitano di nave mercantile, e di Orsetta, frequentò a quattordici anni la bottega di Gregorio Lazzarini, la cui maniera diligente ben presto abbandonò per guardare piuttosto al Bencovich e al Piazzetta: dal primo trasse il gusto per la tensione lineare, dal secondo il senso del colore; né gli fu sconosciuta la fragrante pittura di Sebastiano Ricci. A diciannove anni dipinse la prima opera pubblica, il Sacrificio di Isacco nella chiesa dell’Ospedaletto di Venezia (in cui si registra anche la presenza di dipinti di Nicola Grassi, carnico). Nel 1719 sposò Cecilia Guardi, sorella dei pittori Giannantonio, Francesco e Nicolò, e da lei ebbe nove figli, due dei quali, Giandomenico e Lorenzo, furono a loro volta pittori ed aiuti del padre. Eseguì alcuni lavori per chiese e dimore veneziane (anche dieci tele con raffigurazioni tratte dalla storia romana a decorazione del palazzo della famiglia Dolfin) finché nel 1726 venne chiamato a Udine dal patriarca Dionisio Dolfin per dipingere nel palazzo patriarcale il cielo dello scalone d’onore che in quel periodo si stava portando a termine. Dipinse San Michele caccia dal Paradiso gli angeli ribelli nel riquadro centrale, e dentro un ricco apparato a stucchi dovuto ad Abondio Stazio, otto freschissime storie della Genesi a monocromo. Al di là dell’interesse per il significato simbolico delle scene, coerentemente inserite in un discorso teologico unitario (tutti gli episodi sono relativi alla disobbedienza al legittimo potere), con forti implicazioni politiche e chiara allusione al comportamento del clero austriaco soggetto al patriarca e alla stessa corte imperiale, i dipinti permettono di valutare la poetica del trentenne pittore, ormai capace di tenere i grandi spazi, di forzare la prospettiva ai limiti della credibilità, di costruire figure aeree ed evanescenti, ma ancora legato ad un mondo secentesco fatto di robustezza plastica, di vuota magniloquenza, di scenica drammaticità esteriore. .
https://www.dizionariobiograficodeifriulani.it/tiepolo-giambattista/










.jpg)
.jpg)