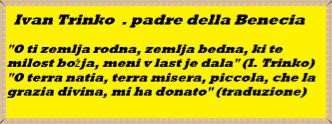di Vita nei campi
“La Madone Ciandelore s’al è nulât el frêt l’è lât, se al è serèn el frêt al ven” Ovvero se per la Madonna Candelora (il 2 febbraio) se il tempo è nuvoloso il freddo se ne è andato, se invece è sereno il freddo viene.

“La Madone Ciandelore s’al è nulât el frêt l’è lât, se al è serèn el frêt al ven” Ovvero se per la Madonna Candelora (il 2 febbraio) se il tempo è nuvoloso il freddo se ne è andato, se invece è sereno il freddo viene.
da vita nei campi
San Marc
 |
| Duomo di San Daniele |
Il comune di San Daniele, arroccato sulla sommità di un colle a 252 m s.l.m., è al centro del Friuli e domina la pianura circostante. Il territorio gode di un'aria particolare che dona ai prosciutti (prodotti localmente), un sapore unico e inconfondibile conosciuto in tutto il mondo. A poca distanza dal colle, le limpide acque del Tagliamento sono la naturale dimora della trota (qui chiamata "la regina di San Daniele") che viene allevata e lavorata in modo artigianale. La città può vantare la vicinanza al Mare Adriatico a sud e alla Carnia a nord. San Daniele era in contatto con San Daniele in Carinzia (Sankt Daniel im Gailtal) collegato con la storia del Patriarcato di Aquileia e con San Daniele del Carso (monte San Daniele) in Slovenia (Stanjel na Krasu) per comune storia originaria. Città raccolta ed accogliente con diversi tesori artistici, fa parte delle Città Slow.
Uno dei centri della Riforma protestante nel Friuli nel XVII secolo, San Daniele del Friuli fu patria dell'erudito e scrittore Giusto Fontanini (1666-1736).
Il terremoto del 1976 arrecò al paese meno danni rispetto agli altri comuni coinvolti, ma si verificarono distruzioni parziali o totali degli edifici del centro storico, meno toccato dagli spezzonamenti, e danni alle opere d'arte, con feriti e vittime, molte delle quali causate dal crollo di una palazzina a pochi passi dal municipio.
Lo stemma e il gonfalone sono stati concessi con decreto del presidente della Repubblica del 21 luglio 1962.
«Di rosso, alla croce di Sant'Andrea d'argento. Ornamenti esteriori da Città.» |
Il gonfalone è un drappo di colore cremisi.
Le ricerche sono state condotte su concessione ministeriale, in accordo con la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia-Giulia e in collaborazione scientifica con Cristiano Tiussi, direttore di Fondazione Aquileia, che ha assicurato il sostegno economico allo scavo.
Il cantiere-scuola
La campagna di scavi è stata condotta, a settembre e ottobre, da un gruppo di ricerca del dipartimento di Studi umanistici e del patrimonio culturale, diretto da Matteo Cadario, coadiuvato da Marina Rubinich. Alle ricerche hanno partecipato 25 studentesse e studenti dei corsi di laurea triennale, in Beni culturali, e magistrale, in Archeologia e Culture dell’antichità, e della Scuola interateneo di specializzazione in beni archeologici. "Tutte le attività di scavo, documentazione e lavaggio dei materiali – sottolineano Cadario e Rubinich – sono state svolte anche allo scopo di preparare al meglio i futuri archeologi ad agire in un cantiere".
Vasche e fontane
Nel settore nord-orientale è stato messo in luce un ambiente di oltre 200 metri quadrati che, nella prima fase delle terme (IV secolo d.C.), ospitava grandi vasche e forse fontane. L’elemento più impressionante è la poderosa fondazione dell’ambiente in calcestruzzo e grossi frammenti di colonne reimpiegate, prevalentemente in marmo cipollino. Sulla struttura, spessa oltre un metro e 60 centimetri, poggiavano vari strati di mattoni intorno a una vasca circolare di otto metri di diametro. Vasche, nicchie e pareti dovevano essere decorate con tessere musive in vetro colorato e lastre sagomate di marmi pregiati, i cui resti si trovano nei riempimenti della fase successiva.
Tra la fine del IV e gli inizi del V secolo, infatti, la vasca circolare fu colmata e l’ambiente ricoperto da un mosaico a grandi tessere con un reticolo di quadrati contenenti grandi fiori stilizzati. Si creò così un nuovo vano rettangolare, lungo 15 metri, che fa parte di una importante ristrutturazione non solo di questo lato nord, ma anche di quello sud, a ben 140 metri di distanza.
Le sistematiche spoliazioni delle strutture murarie condotte a partire dal tardo Medioevo hanno asportato tutti i muri fino a notevole profondità, rendendo molto difficile la lettura delle diverse fasi. Tuttavia, qualche raro documento dell’antico lusso dei frequentatori delle Grandi Terme si è salvato. Tra questi un grano di collana in vetro a stampo con una minuscola testina femminile databile, per la sua acconciatura, al III secolo d.C., rinvenuto proprio in uno di questi riempimenti. Lo scavo in quest’area è stato guidato da Marina Rubinich, con il supporto di un piccolo nucleo di professionisti, studenti e specializzandi affidato a Luciana Mandruzzato.
Il calidarium
Nel nuovo scavo nel settore occidentale, che ha interessato un’area di circa 150 metri quadrati, è stata messa in luce quasi completamente l’ampia abside del calidarium, la parte delle terme destinata ai bagni in acqua calda e di vapore, con cui l’edificio si concludeva. Dell’abside dissestata dai crolli delle volte e priva del muro di fondo asportato successivamente, si conserva la massiccia preparazione del pavimento, caratterizzata dall’inserimento di centinaia di lastrine in marmi colorati. L’identificazione del calidarium è assicurata dalla presenza del doppio sistema di riscaldamento a ipocausto (pavimento sopraelevato sostenuto da pilastrini lapidei) e a parete (intercapedine formata da grandi tubuli fittili rettangolari). Entrambi erano alimentati dalla circolazione di aria calda proveniente dai forni.
Intorno all’abside è stata poi riconosciuta la presenza di una piattaforma in laterizi, ampiamente spoliata, pertinente ad ambienti di servizio, tra cui almeno due praefurnia (i forni dove si bruciava la legna), gli imbocchi dei quali sono stati parzialmente messi in luce. La presenza di spessi livelli di bruciato nell’ipocausto e il deterioramento dei pilastrini dovuto al forte calore dimostrano che il calidarium è stato utilizzato a lungo. E questo nonostante le dimensioni e gli alti costi del suo funzionamento, il che costituisce un’ulteriore prova della vitalità dell’Aquileia tardoantica. Lo scavo nell’area, organizzato come cantiere-scuola, è stato eseguito da Chiara Bozzi e Federica Grossi, sotto la diretta supervisione di Matteo Cadario. "La scoperta dell’abside – spiega Cadario, docente di archeologia classica – consentirà in futuro di allargare lo scavo allo scopo di mettere in luce integralmente l’area riscaldata dell’edificio".
"Le Grandi Terme con la loro imponenza rappresentavano un tratto distintivo della grandezza di Aquileia in età imperiale – spiega la Soprintendente del Friuli Venezia Giulia, Simonetta Bonomi –. Indagarne i resti e comprenderne lo sviluppo funzionale e costruttivo, come sta da tempo facendo l'Università di Udine, costituiscono sia una meritoria e importante impresa scientifica sia il presupposto imprescindibile per una futura valorizzazione".
"I risultati dello scavo delle Grandi Terme sono per la Fondazione Aquileia – sottolinea il direttore, Cristiano Tiussi – di grande importanza perché la prospettiva della valorizzazione di questo straordinario ed enorme edificio dovrà rappresentare, per tutti noi, una sfida ineludibile in un futuro non troppo lontano".
L’Università di Udine ad Aquileia
La presenza dell’Ateneo friulano alle Grandi Terme è ormai consolidata da due decenni e nelle campagne di scavo annuali si sono formati oltre 600 studenti di archeologia. Dal 2016, anno della prima concessione di scavo dal Ministero, allora dei beni e delle attività culturali, fu avviata una nuova e proficua collaborazione con la Soprintendenza e la Fondazione Aquileia, che aveva appena acquisito l’area in gestione.
Storia e caratteristiche dell’edificio
Le Grandi Terme di Aquileia, o Thermae felices Constantinianae, come sono chiamate nell’iscrizione di una base di statua di Costantino rinvenuta nell’area, furono costruite (o completate) per volontà di Costantino stesso nel corso dei primi decenni del IV secolo d.C. Allora Aquileia era uno dei porti principali del Mediterraneo e ospitava spesso l’imperatore. La loro collocazione nella zona sud-occidentale della città, nella località detta poi Braida Murada adiacente a Via 24 Maggio, tra l’anfiteatro e il teatro, suggerisce la progettazione di un grande quartiere dedicato all’otium e alle attività ludiche, protetto dalle nuove mura tardoantiche. Gli scavi dell’Università di Udine, ricollegandosi a quelli condotti dalla locale Soprintendenza archeologica nel corso del ‘900, hanno permesso di ricostruire un edificio “fuori scala” anche per una città importante come Aquileia, con elevati superiori a 10 metri e con un’estensione pari a circa 2,5 ettari (25.000 metri quadrati), paragonabile quindi solo alle grandi terme imperiali pubbliche costruite a Roma da Caracalla, Diocleziano e Costantino stesso.
Un intervento di questa portata dimostra la volontà di Costantino di dotare anche Aquileia, come le altre città divenute residenze imperiali alla fine del III sec. d.C. (Milano, Trier, Arles, Antiochia), di una magnifica struttura termale, adeguata al suo ruolo strategico e degna della frequentazione della corte. Nelle terme imperiali l’edificio era organizzato intorno a un asse centrale formato dalle aule che offrivano di bagnarsi consecutivamente in acque di temperature diverse (calda, tiepida e fredda) secondo il modello di pratica balneare peculiare del mondo romano.
Gli scavi hanno finora rivelato: ampi saloni pavimentati con raffinati mosaici policromi geometrici e figurati o in tarsie di pietre e marmi multicolori; l’enorme frigidarium, con le sue grandi vasche per i bagni freddi; la parte centrale della grande piscina (natatio) lastricata in cui si poteva nuotare; gli ambienti del settore nord-orientale, dove è ancora visibile la sovrapposizione di tre fasi successive con i rispettivi mosaici; alcuni ambienti riscaldati del settore occidentale.
In particolare, dalla grande aula nord provengono i mosaici di eccezionale pregio oggi conservati al Museo archeologico nazionale di Aquileia e raffiguranti soggetti marini e atletici. Ossia i temi caratteristici della decorazione delle terme imperiali, dove erano previsti spazi per agonismo e training sportivo. Le didascalie in greco provano l’intervento di raffinate maestranze di origine greca/orientale.
I rifacimenti e i restauri dei mosaici dimostrano che le terme costantiniane continuarono a vivere fino al termine del V secolo d.C., anche oltre il famoso saccheggio di Attila del 452 d.C. Tra il VI e il VII secolo i ruderi furono riutilizzati a fini abitativi da piccoli nuclei familiari e, dopo il definitivo abbandono e il crollo delle volte e degli elevati, diventarono una grande cava di pietre e mattoni da riutilizzare come materiale da costruzione o da cuocere per ottenere calce.
La spoliazione dei resti delle terme si intensificò in età tardomedievale (XIII-XIV secolo), eliminando tutti i resti delle strutture fino alle fondazioni dei muri. Così si trasformò completamente l’aspetto del sito, che prima dell’inizio degli scavi moderni si presentava come un campo coltivato, proprio grazie a grandi riporti di terra disposti sulle macerie.
Oggi delle terme si conservano quindi solo i pavimenti e le trincee di spoliazione dei muri depredati fino all’età moderna.
Varie zone dell'edificio sono state indagate più volte nel corso del XX secolo dalla locale Soprintendenza e da alcuni dei nomi più noti dell’archeologia aquileiese: Giovanni Battista Brusin (1922-1923); Luisa Bertacchi (1961); Paola Lopreato (1980-1987). "Gli scavi del ‘900 – spiegano Cadario e Rubinich – furono però pubblicati solo in parte e soltanto con le nuove metodologie di scavo stratigrafico, introdotte nel 2002 con l’inizio delle attività dell’Ateneo udinese, è stato possibile ricollegare i nuovi ritrovamenti a quelli pregressi e indagare non solo le fasi di epoca romana, ma anche quelle che dal Medioevo a oggi hanno reso il sito un paesaggio prevalentemente agricolo".https://www.ilfriuli.it/articolo/cultura/aquileia-le-grandi-terme-svelano-due-settori-inesplorati/6/274462
di Vita nei Vita Nei Campi
“A Sante Catarine el frêt al busine” ovvero A Santa Caterina, il 25 novembre, il freddo “rumoreggia” fischia, urla.
(ACON) Udine, 19 ott - "Questa è una delle piccole giornate che fanno grande una Regione". Il presidente del Consiglio regionale, Piero Mauro Zanin, ha scelto un riferimento implicito al più celebre primo passo della storia del Novecento, quello dell'astronauta Neil Armstrong, per sottolineare l'importanza del nuovo sito Internet dell'Assemblea legislativa Fvg. Che non è un semplice restyling, ma in qualche modo una rivoluzione in quanto da oggi le informazioni per i cittadini si possono leggere in quattro lingue: friulano, sloveno e tedesco, oltre all'italiano naturalmente.
Le comunità di lingua tedesca nel territorio friulano
Le comunità di lingua germanica disseminate lungo le aree alpine del Friuli ( link all’articolo di Marco Caria ) hanno avuto fin dall’inizio caratteri di insediamenti spontanei da parte di gruppi esigui di persone, allontanatisi verosimilmente dalle valli carinziane nel corso del XIII sec. alla ricerca di occupazione nell’estrazione mineraria (a Sappada/Plodn, ora in provincia di Belluno e a Timau/Tischlbong, ca. 700 abitanti, nella valle del But) o di sfruttamento di terre spopolate (a Sauris/Zahre, ca. 500 abitanti, nell’alta valle del Lumiei). Diversa è la vicenda dei tedescofoni della Val Canale/Kanaltal (con i centri principali di Pontebba/Pontafel e Tarvisio/Tarvis) sudditi fino la 1918 dell’Impero Austro-Ungarico. Si tratta di comunità che usano varietà di tedesco o austro-bavarese, talora a stretto contatto con sloveno e friulano in contesto plurilingue. Negli ultimi decenni si osserva, in specie fra i giovani, un progressivo cedimento delle antiche parlate: tale regresso è in parte rallentato dalla riscoperta delle proprie origini e da una più matura consapevolezza linguistica, favorite da molteplici iniziative promosse dalle associazioni culturali e dalle istituzioni locali.
Le comunità slovenofone del Friuli Venezia Giulia
Trovano spazio lungo la fascia montuosa e collinare del confine nord-orientale tra Italia e Slovenia. Parte di quest’area (alta valle del Torre e valli del Natisone), appartenente alla provincia di Udine, è anche nota, per l’antica dipendenza dalla Repubblica di Venezia, come Benècija o SlaviaVeneta. Dal punto di vista linguistico, le comunità slovenofone sono suddivise in vari gruppi dialettali da nord verso sud: lo zegliano (zilijsko), propaggine italiana, acquisita dopo il primo conflitto mondiale, del dialetto della valle carinziana di Zeglia, ancora diffuso in alcuni centri della Val Canale (KanalskaDolina), a contatto con dialetti tedeschi e i friulani; il resiano (rezijansko), in uso nei paesi della Val di Resia, che, esibendo tratti conservativi, rappresenta un caso a sé tra i dialetti sloveni del Friuli; il tersko, cioè i dialetti del Torre, sulle Prealpi, con diramazioni verso l’area pianeggiante; il nadiško, ossia i dialetti della Val Natisone (e delle valli contermini), tipo più vitale ed esteso. A questi si affiancano le varietà della provincia di Gorizia (briško cioè del Collio o collinare) e di Trieste (kraško, parlato prevalentemente nei paesi del Carso).Di tale articolata compagine va sottolineato che gli slavofoni della fascia prealpina orientale del Friuli hanno saputo preservare fino ai nostri giorni la loro antica parlata avvantaggiati dal relativo isolamento in cui si sono trovati i loro insediamenti, situati in aree scarsamente popolate, e dal tenace radicamento alle origini etnico-linguistiche. Sul piano del riconoscimento e della tutela, gli sloveni della Provincia di Udine sono stati lasciati un po’ nell’ombra fino all’entrata in vigore della legge 38/2001, che intrducendo “Norme per la tutela della minoranza linguistica slovena della Regione Friuli-Venezia Giulia”, ha promosso una significativa politica linguistico-culturale di sviluppo degli idiomi locali; alla normativa statale si sono poi affiancati provvedimenti regionali. Diverso è stato il trattamento riservato alle altre comunità slovene della regione, che godono della tutela da parte dello Stato, in particolare nel settore scolastico, prevista alla fine del secondo conflitto mondiale dal Memorandum di Londra del 1948 e poi dal Trattato di Osimo del 1975.Gli abitanti delle aree slovenofone non sono concordi nella scelta degli strumenti e del modello linguistico da proteggere e promuovere, che alcuni vorrebbero appiattire sullo sloveno letterario, ritenuto in grado di salvaguardare anche l’identità linguistica delle valli della provincia di Udine. A tale opzione si oppone tuttavia una parte consistente della popolazione, che vi ravvisa un tentativo di imporre una lingua che non percepisce come sua (lo sloveno letterario), a svantaggio delle parlate locali, che sono considerate invece il patrimonio da tutelare. La ragione di tale atteggiamento dipende anche dalla consapevolezza che esiste un forte legame partecipativo con le vicende storiche e culturali del Friuli (e indirettamente, dell’Italia) mentre i rapporti con gli Sloveni dell’opposto versante alpino, seppur mai interrotti, non sono stati mai così stringenti. Fino a qualche anno fa, inoltre, ribadire le relazioni di parentela linguistica coi vicini della ex Repubblica Iugoslava assumeva in alcune comunità il valore di accettazione di un simbolo politico sgradito a molti.
fonte https://www.treccani.it/magazine/lingua_italiana/speciali/minoranze/Fusco.html
Prenderà il via tra una settimana la 36esima festa del Prosciutto di San Daniele nella formula Aria di Friuli Venezia Giulia: la kermesse enogastronomica è in programma dal 26 al 29 agosto a San Daniele del Friuli.
Aria di Festa, la storica manifestazione che da oltre 35 anni celebra il Prosciutto di San Daniele Dop nel suo luogo d’origine, ritorna - solo per quest’anno e dopo quasi vent’anni - a fine agosto per un’edizione speciale che promuove, oltre all’eccellenza dell’enogastronomia friulana, anche sei itinerari turistici lungo un’ideale via dei Sapori e del prosciutto che si estende delle Alpi all’Adriatico, realizzata grazie alla stretta sinergia tra Consorzio e Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.
Appuntamenti sold out e boom di prenotazioni
Già a partire dalle conferenze stampa di luglio svoltesi a Milano e Udine, Aria di Friuli Venezia Giulia ha suscitato grande interesse da parte del pubblico, subito confermato dal boom di prenotazioni sul sito web dell’evento. Oltre 2.600 le prenotazioni ricevute per i laboratori e le degustazioni. Le attività con prenotazione obbligatoria sono ormai quasi esaurite. Il 62% degli ospiti che si è prenotato proviene da fuori regione in prevalenza Veneto, Lombardia e centro Italia.
Numerose le richieste di bus turistici dal Nord Italia e dall’Austria. La maggior parte dei posti per i laboratori di degustazione del San Daniele si è esaurita già nella prima settimana di agosto, rendendo necessaria l’implementazione degli appuntamenti per garantire le numerose richieste di approfondimento sul prosciutto Dop in abbinamento ai vini, alle birre e agli altri prodotti enogastronomici regionali.
Anche le visite guidate organizzate nei “Prosciuttifici aperti” hanno stimolato gli ospiti: oltre 1.500 le persone che hanno già prenotato le visite per scoprire i segreti del San Daniele, subito attivati altri appuntamenti nei prosciuttifici proprio per assicurare ulteriori disponibilità.
Grande interesse per le visite alla Biblioteca Guarneriana e per i pic nic organizzati sabato 27 e domenica 28 agosto con ancora pochi posti disponibili. Sold out anche per il treno storico ‘Arlecchino’ in partenza da Trieste programmato per la giornata di domenica 28 agosto, ultimi posti disponibili solo con partenza da Udine.
L’inaugurazione
A dare il via alla prima serata di Aria di Friuli Venezia Giulia, venerdì 26 agosto alle 18.45, sarà l’esibizione della Banda dell’Aeronautica Militare Italiana sulla suggestiva scalinata del Duomo di San Daniele del Friuli. Alle 19.30 taglio della prima fetta del Prosciutto di San Daniele, l’atto simbolico inaugurale tenuto a battesimo dalla giornalista sportiva di Sport Mediaset Eleonora Boi e dal conduttore radiofonico di RDS Filippo Ferraro.
Il programma
Nella città del prosciutto, da venerdì 26 a lunedì 29 agosto, saranno presenti 15 stand enogastronomici lungo le vie del centro storico che proporranno degustazioni di Prosciutto di San Daniele con proposte e ricette gourmet, abbinamenti con latticini e frutta e molto altro. Nella suggestiva Terrazza affianco alla Chiesa della Fratta sarà allestita l’enoteca dedicata ai vini del FVG e, dopo il successo del format itinerante, questa edizione prevederà i picnic nella splendida cornice di Villa Seravallo.
Non mancheranno le visite guidate alla città di San Daniele a cui si aggiungono altrettante attività alla scoperta del Friuli Collinare e del fiume Tagliamento. Confermati gli appuntamenti per i bambini e le famiglie con spazi dedicati in Piazza IV Novembre, dove sarà ospitato il mercato delle aziende aderenti al marchio “Io sono Friuli Venezia Giulia”. Per tutta la durata della manifestazione, PromoTurismoFVG sarà presente anche con un’area istituzionale in via Umberto I dedicata alla promozione del comparto agroalimentare e vitivinicolo: una vetrina sui prodotti e le bellezze della regione a cui parteciperanno anche alcuni operatori del territorio per raccontare la loro offerta turistica e saranno a disposizione dei visitatori per presentare le diverse opportunità del Friuli Venezia Giulia. Inoltre, saranno organizzati dei laboratori per bambini a tema cibo, natura e sostenibilità nelle giornate di sabato 27 e domenica 28 agosto.
Gli eventi diffusi
Dal 22 al 25 e il 30 e 31 agosto nei sei percorsi lungo la Strada del Vino e dei Sapori si svolgeranno numerosi appuntamenti per vivere un’esperienza autentica tra cultura e tradizioni e conoscere i prodotti locali, immergersi nella natura incontaminata. Un palinsesto per scoprire la storia della regione attraverso laboratori per bambini, esperienze outdoor ed enogastronomiche serali, per ognuno dei sei itinerari che compongono la Strada. Lunedì 22 agosto eventi dedicati all’itinerario della montagna con tappe a Sappada per un’escursione alla scoperta del borgo, letture espressive a Tarvisio e picnic sul Monte Zoncolan.
A seguire martedì 23 agosto le attività in pianura: Molin Nuovo, Sedegliano e Nespoledo ospiteranno escursioni ebike, trekking sul Tagliamento e picnic. Mercoledì 24 gli appuntamenti sul Carso
a Duino con le passeggiate in fattoria, a Trieste per una degustazione carsica e il picnic a San Dorligo della Valle. Giovedì 25 gli appuntamenti nell’itinerario sul fiume partiranno dal soft rafting a Sacile e si concluderanno con la cooking class a Vivaro ed il picnic a Pinzano al Tagliamento.
Dopo la pausa per i quattro giorni a San Daniele del Friuli, le attività itineranti riprenderanno lunedì 30 agosto in Riviera per un safari archeologico e picnic ad Aquileia ed escursione in canoa alla Riserva Naturale Foci dello Stella.
Gli appuntamenti diffusi si concluderanno martedì 31 agosto con gli itinerari sui Colli: passeggiata onodidattica a Gorizia, rafting sul Tagliamento e picnic in casale a Fagagna.
Tutte le informazioni sull’evento sono disponibili sul sito: eventi.prosciuttosandaniele.it
https://www.ilfriuli.it/articolo/gusto/al-via-aria-di-friuli-venezia-giulia/10/270449
21 agosto 2022
Lunedì 29 agosto, nel cuore di Udine, si terrà la seconda edizione della Summer School di LeggiAmo 0-18: una giornata di alta formazione dedicata a docenti, bibliotecari, operatori e amministratori regionali.
Un’esperienza formativa di aggiornamento, per parlare insieme di libri, promozione della lettura, strategie di lettura inclusiva, nuovi punti di vista. La Summer School di LeggiAmo 0-18, progetto di promozione alla lettura della Regione, è resa possibile grazie alla virtuosa sinergia dei Partner del progetto: CCM – Consorzio Culturale del Monfalconese (coordinatore), CSB – Centro per la Salute del Bambino Onlus, Damatrà Onlus, AIB Associazione Italiana Biblioteche – Sezione FVG, Fondazione Radio Magica Onlus. L’edizione 2022 è realizzata in collaborazione con il Comune di Udine, la Biblioteca Civica “Vincenzo Joppi” e i Civici Musei di Udine e con il patrocinio di Anci Fvg.
Tre i percorsi formativi proposti (Linea Arancio, Linea Verde e Linea Argento) che traggono ispirazione dalle parole chiave del Manifesto di LeggiAMO 0-18: “tempo”, “libri”, “relazione” e “comunità”. I relatori che condurranno i percorsi formativi sono nomi di spicco nel panorama della formazione, dell’infanzia, della ricerca e della promozione della lettura: Amanda Saksida, ricercatrice e docente; Giorgio Tamburlini, pediatra, esperto di salute dell’infanzia; Fabio Geda scrittore ed educatore; Grazia Gotti autrice, pedagogista e formatrice; Tiziana Mascia ricercatrice e pedagogista; Federico Scarioni scrittore e consulente letterario…continua a leggere https://www.ilfriuli.it/articolo/cultura/torna-la-summer-school-di-leggiamo-0-18/6/270439
"Si tratta di un altro importante tassello lungo il percorso culturale e sociale che ci porterà alla Capitale europea della cultura, ma è anche un ulteriore passo in avanti nell'ambito di un progetto più ampio per rilanciare Gorizia". Lo afferma in una nota il consigliere regionale Diego Bernardis (Lega), presente insieme ai sindaci di Gorizia e Nova Gorica, Rodolfo Ziberna e Klemen Miklavič, all'assessore comunale alla Cultura, Fabrizio Oreti, al presidente e alla direttrice del Gect Go, Paolo Petiziol e Romina Kocina, alla presentazione del logo definitivo di Nova Gorica e Gorizia Capitale europea della cultura 2025, svoltasi a casa Morassi - Casa Panizzolo di Borgo Castello a Gorizia.
"Si tratta - spiega l'esponente del Carroccio - di un sistema tipografico originale e diretto, al contempo accattivante e innovativo, sicuramente declinabile per tutti gli usi comunicativi e di promozione".
"Complimenti allo Studio but maybe e ai tre giovani di Bologna che hanno creato il logo. Ora diventa a tutti gli effetti - conclude Bernardis - un patrimonio e una proprietà di Gorizia e Nova Gorica che contribuirà a valorizzare e a divulgare al meglio la splendida opportunità della Capitale europea della cultura 2025".
Maggio risveglia i nidi, maggio risveglia i cuori; porta le ortiche e i fiori, i serpi e l’usignol. Schiamazzano i fanciulli in terra, e i...