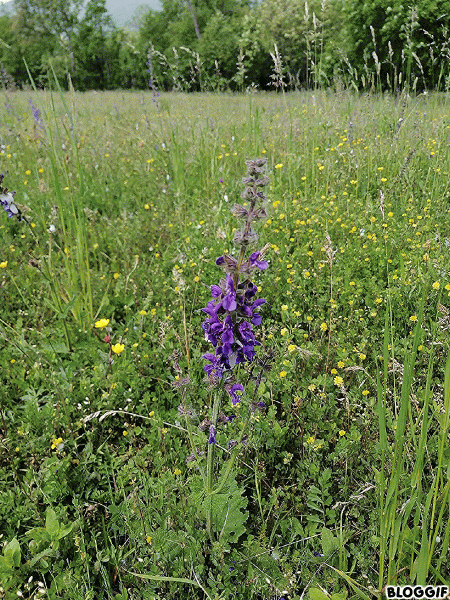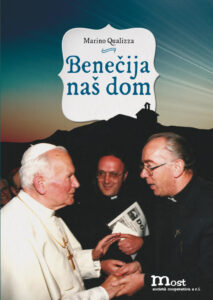RESIA – REZIJA
Il destino di Uccea/Učja si è compiuto
Il paese del comune di Resia/Rezija è paradigma
dello stato di abbandono delle valli abitate da sloveni
Una breve intervista riportata su Facebook, ripresa
da Telefriuli, notizia con nulla di eclatante, quasi una
curiosità, tanto per riempire il palinsesto: «Niente telefoni, nessun abitante. Uccea, un paese che non c’è
più». A chi può interessare un vuoto creatosi all’interno
di uno scenario da vecchia favola in una valle montana
di per sé stessa negletta e sperduta?
Uccea/Učja, un paesino nascosto in fondo ad una
stretta valle ai piedi del gigantesco massiccio del Canin, a un tiro di sasso dal confine sopra il torrentello
omonimo che porta le sue acque verso l’Isonzo in Slovenia. Frazione del comune di Resia/ Rezija, il cui capoluogo comunale si trova in un’altra valle che scende
dal gigante montano; ci vogliono 17 km, superando
sella Carnizza (1.086 m.s.l.m.), per raggiungerlo; e, fino
a poco tempo addietro, a piedi, d’estate e d’inverno.
Paesino, Uccea, ai cui piedi oggi corre una ex strada
statale transfrontaliera (la 646); è dotato di due chiesette – una antica (S. Antonio) lontana dal centro già abitato ed una più recente; aveva una scuola – demolita
dopo il terremoto del 1976 –, un paio di osterie, casette
dignitose per gente caparbia. Ora, la presa d’atto: l’abbandono totale alla stregua di tanti altri paesetti dove
la vita normale pare divenuta impossibile. Porte sprangate, non fiori sui davanzali, campane mute, strade silenziose, ortiche negli orti a riconfermare l’abbandono.
Silenzio.
Neppure io ne scriverei se quello non fosse per me
un luogo di particolari ricordi, di forti emozioni, di lavoro impegnativo e gratificante. Era l’anno 1974, il mio
secondo anno come maestro elementare. Dopo una
iperattiva supplenza annuale a Drenchia nel troppo
grande edificio scolastico per una dozzina di alunni,
con un punteggio minimale potevo scegliere una sede
di ruolo solo tra qualche paesino montano della lontana Carnia, tipo Lauco o Ovaro, e Uccea, la più vicinaIn ricognizione, mi sono avventurato sulla strada di
Lusevera e, superando il passo Tanamea/Ta na meji,
scesi lungo la valle, per me del tutto ignota, fino al paesello un po’ disperso sul versante sinistro del torrente.
Non sapevo che il mio futuro collega sarebbe stato
un prete. Che ci facesse là era per me un rebus, ma non
mi mancò l’opportunità di comprenderlo già da subito,
quando, ricevuto nella disadorna canonica autogestita, conobbi don Vito Ferrini. Nel colloquio, che potrei
definire fraterno, compresi il suo particolare modo di
gestire la vita in quel piccolo mondo, non solo la specifica conduzione pastorale e scolastica, ma l’impegno
totale e disinteressato per tutta la comunità che a lui
faceva riferimento. «Qui, lo puoi vedere da solo, – mi
diceva – la vita è difficile soprattutto per i ragazzi. Già
a partire dalla lingua, un antico dialetto sloveno, contando anche l’isolamento dal resto del mondo. Le case
sparse sul ripido versante in piccoli agglomerati lo acuiscono e così la chiesa e la scuola diventano gli unici
strumenti e occasioni di aggregazione, di socializzazione e conoscenza. Neppure la Tv, un telefono pubblico...
Qui i ragazzi stanno a scuola dal primo mattino al tardo
pomeriggio – colazione, pranzo e merenda compresi,
cui provvedeva coi propri mezzi –, altrimenti quei pochi rimasti rimarrebbero inselvatichiti come cuccioli
allo stato brado».
Mi è sembrato da subito un uomo e prete particolare e pensai istintivamente a don Lorenzo Milani e alla
scuola di Barbiana. Questo qui, mi dissi, dopo aver a
lungo colloquiato e discusso sul mio futuro impegno,
ha preso sul serio il suo ministero e a me non rimane
che mettermi in sintonia con lui, perché anche per me
fare l’insegnante non doveva rimanere un qualsiasi
lavoro, ma una missione, perché quei deliziosi ragazzi
affidatimi richiedevano senso di responsabilità, sensibilità e dedizione. In fondo sarei stato corresponsabile
della vita quotidiana di quella particolare dozzina da
sei a otto ore per cinque giorni alla settimana. Accettai senza rimpianti, anche se, come mi avvertì don Vito,
la strada da Tanamea al paese dopo la terza nevicata
diveniva una pista da bob, comunque aperta per via
della caserma della Finanza a custodia del valico. A distanza di tanto tempo ricordo in particolare i tre ragazzini più piccoli, Roberto, Marcellino e Vito, cui qualche
volta scappava di chiamarmi mamma.
Ecco perché mi ha colpito la notizia di quel piccolo
mondo che affonda la propria storia agli inizi del XVI
secolo, che contava negli anni 50 del secolo scorso
oltre 400 residenti. Nelle sere, soprattutto quelle invernali, nel piccolo alloggio ricavato nei locali della
scuola, consultavo e trascrivevo i particolari di quella
popolazione rimasta (110 residenti), annotavo le caratteristiche, il modo di vita, il senso di quella resistenza.
Già allora non mi facevo illusioni e assieme a don Vito ci sforzavamo di preparare i ragazzi al mondo più ampio
che inevitabilmente li avrebbe attratti e dispersi. Don
Vito aveva la mappa dettagliata di tutte le famiglie,
delle persone rimaste e di quelle che se n’erano andate
in cerca di fortuna e di sole. E io, per la prima volta mi
cimentai nella lettura del dialetto resiano, così come
riportato dallo studioso Milko Matičetov. Mi meravigliavo, accorgendomi di poter comprendere, col mio
dialetto delle Valli del Natisone, quello del posto. Così
con quei ragazzi mi sentivo di condividere memorie e
valori.
Il destino di Uccea/Učja – chiamiamo così questa sua
prevedibile parabola storica – si è compiuto. Rimane
un ricordo e il rimpianto constatando che per prime ad
abbandonarlo sono state le pubbliche istituzioni. Uno
dei luoghi della nostra storia, emblema di tanti altri
nostri paesini su cui incombe la stessa sorte. E questo
mio scritto non è che uno sconsolato De profundis col
cuore affranto per il probabile analogo destino di molti
paesi delle mie Valli slovene.
Riccardo Ruttar
(Dom, 15. 9. 2019) da SLOVIT