Il testo narra la concessione della Carnia, da parte dei tedeschi, al popolo cosacco, che in cambio di questa terra dove vivere avrà il compito di scovare i partigiani sulle montagne."L’armata dei fiumi perduti" è un testo che narra una vicenda poco conosciuta, quanto incredibile, avvenuta verso la fine della Seconda guerra mondiale. Se non incredibile potrebbe essere surreale, appartenere a un film di Bunuel e invece è Storia. Storia che non viene raccontata nei libri di testo, che i giovani non conoscono. Per fortuna Sgorlon, scrittore friulano, da fatti realmente avvenuti, trae spunto per un romanzo lineare, quanto spietato.
In breve, il testo narra della concessione, da parte dei geni malefici tedeschi, della Carnia al popolo dei cosacchi. Cosacchi o tartari, erano a quel tempo un popolo allo sbando alla ricerca di una terra dove vivere. Sicché eccoli arrivare dalla Polonia con tutte le famiglie e le masserizie al seguito, giungere con decine di treni alla stazione di Carnia in oltre ventimila tra uomini, donne, vecchi, bambini, cavalli e perfino cammelli e dromedari. I cosacchi in cambio di quella terra concessa dai tedeschi dovevano snidare i partigiani dalle montagne. Un gruppo di loro s’insedia nelle case di un paesino come ospiti non graditi.
A questo punto emerge la figura della protagonista, Marta, una donna giovane e forte che aveva perso il marito in Russia. Sarà lei a fare da tramite tra i cosacchi invasori e la popolazione. Ma ben presto, i Cosacchi stessi capiranno l’inganno dei tedeschi, sradicati dalle loro steppe per correre verso un’illusione, quando questa si dissolverà come il vento, diverranno selvaggi e assassini, lasciando dietro di sé una scia di sangue su quella terra che li aveva accolti, mentre fuggono andando incontro al loro tragico e ineluttabile destino. L’Austria potrebbe essere la via di fuga, ma sarà solo il loro cimitero. Per evitare di essere riconsegnati all’Armata Rossa, la gran
parte di essi si getterà nelle fredde acque della Drava, in uno dei più grandi suicidi di massa che la storia umana ricordi.
da https://www.sololibri.net/L-armata-dei-fiumi-perduti-Sgorlon.html
I cosacchi del Kuban, durante il secondo conflitto mondiale, occuparono le montagne della Carnia, in Friuli, insediandosi nella piana di Cavazzo, ribattezzata da essi "Nuova Krasnodar". I legami culturali e storici stabilitisi tra le due regioni sono molteplici. Un convegno intitolato "Caucasica Latinitas" ne ha esplorato le trame, lo scorso fine settimana a Krasnodar.
Avente per tema le "relazioni tra il mondo mediterraneo e le regioni caucasiche", il ciclo di conferenze si è svolto domenica 4 maggio nella città della Russia Meridionale, lungo il fiume Kuban, nelle vicinanze del Mar Nero, in una terra geograficamente straordinaria, caratterizzata da una fiorente agricoltura e dalla bellezza dei paesaggi che spaziano dalle colline dolcemente degradanti verso il mare alle asprezze della catena del Caucaso.
Promosso dalla Fondazione Cassamarca di Treviso in collaborazione con l'Ente Friuli nel Mondo e l'Istituto Tecnico "Giuseppe Marchetti" di Gemona del Friuli, che da anni intrattiene rapporti di scambio con la scuola "Gymnazija 69" di Krasnodar, l'evento è stato la tappa conclusiva di un percorso di lavoro condiviso tra professori e studenti russi e friulani cominciato qualche anno fa.
La presenza dei cosacchi in Carnia è stata infatti oggetto di una ricerca storica iniziata nel 2005, quando gli studenti italiani dell'istituto Marchetti di Gemona sono entrati in contatto con i loro coetanei russi del Ginnasio 69. Ritrovandosi assieme in una sorta di aula virtuale, i ragazzi hanno svolto indagini parallele sui due territori, a più di 2.000 km di distanza, coordinati dai professori Valentina Parachnievich e Angelo Floramo, approfondendo il fenomeno dei cosacchi di Krasnodar che nel 1944 e 1945 occuparono buona parte del Friuli a seguito delle armate germaniche. Per mesi gli studenti hanno raccolto dati, progettato moduli didattici, comparato materiale, arrivando a ripercorrere le suggestive e controverse vicende che avevano visto intrecciati i destini dei rispettivi popoli.
Storicamente, il Kuban entrò a far parte dell'impero zarista solamente agli inizi del XVIII secolo, quando la zarina Caterina sottrasse quei territori ricchissimi all'Impero Ottomano ormai in fase di decadenza. Nel corso del VI secolo, la regione era stata occupata da tribù slave che avevano intrattenuto stretti contatti con il mondo bizantino. L'orda d'oro di Tamerlano il Grande aveva quindi investito l'intera regione, per amministrarla fino alla dissoluzione del suo impero. Dopo il 1453, a seguito della caduta di Costantinopoli, la Sublime Porta inglobò quei territori sotto il suo controllo e li mantenne fino a quando le armate cosacche li conquistarono agli zar, insediandovi i loro villaggi.
Furono proprio i cosacchi di Krasnodar a giungere tra le montagne friulane in pieno periodo bellico, in quanto alleati dei tedeschi, con la prospettiva di viverci con le loro famiglie. Gli abitanti del luogo li chiamarono "invasori": pur avendo subito violenza dai sovietici, essi si comportarono in terra italiana con non meno brutalità dei loro persecutori. In seguito furono traditi dai loro superiori nazisti. La ricerca parallela degli studenti di Gemona e di Krasnodar è dedicata alle vittime del totalitarismo: russi, italiani, tedeschi, assieme a tutti i popoli coinvolti nel turbine sanguinoso della violenza...continua https://www.balcanicaucaso.org/Tutte-le-notizie/Sui-passi-dei-cosacchi-in-Friuli-41556









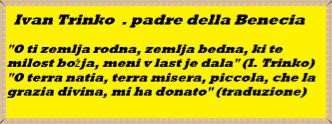
Olga very interesting text.
RispondiElimina