Nella provincia di Udine si conservano alcune preziose testimonianze scritte che documentano l’importanza di quest’area per la storia linguistica e culturale slovena e che, in ragione delle lampanti situazioni di contatto fra diverse lingue in esse riflesse, hanno un indubbio significato anche per la civiltà linguistica del Friuli. Mentre il più antico documento scritto in resiano, comunque solo settecentesco, la Cra(t)ka Dottrina cristian(s)ca, era passato dal conte Jan Potocki alla biblioteca Ossolin´ski a Breslavia, prima che se ne perdessero le tracce, la sorte riservata alle altre più antiche testimonianze vergate in varie forme di sloveno in quest’area è stata almeno parzialmente più fortunata. Il Manoscritto di Cergneu (in sloveno Åernjejski rokopis) è oggi per esempio conservato presso il Museo Archeologico Nazionale di Cividale. Si tratta dell’Anniversario di Legati latino-italiano-slavo della confraternita di S. Maria di Cergneu, studiato e pubblicato tra la fine dell’Otto e l’inizio del Novecento da Vatroslav Oblak e quindi da Jan Baudouin de Courtenay. Le annotazioni di varie mani, fatte in una lingua, o koinè, priva di particolari tratti dialettali della Val Torre o della Val Natisone, datano dalla fine del XV secolo (1497?) e si estendono per alcuni decenni. Il Manoscritto di Castelmonte (Starogorski rokopis), che fa parte del Libro della fraternità di Santa Maria del Monte, consistein due pagine, risalenti verosimilmente agli anni 1492- 1498 e contenenti il Padre nostro, l’Ave Maria e il Credo. Questi testi sono stati scoperti soltanto negli anni sessanta del secolo scorso, e in seguito pubblicati da Angelo Cracina; conservati inizialmente presso l’Archivio arcivescovile di Udine, la loro collocazione attuale è tuttavia ignota. Particolarmente interessante risulta il loro confronto con il Manoscritto di Klagenfurt (Celovski rokopis), che conserva le medesime tre preghiere. Il Manoscritto di Udine (Videnski rokopis), conservato nella Biblioteca civica «Vincenzo Joppi» reca la trascrizione, effettuata nel 1458 a opera di tale «Nicholo Pentor», di una serie di numeri – le unità fino al quarantadue, le centinaia fino a cinquecento, le migliaia fino a duemila soltanto. Al di là del loro rilievo solo apparentemente modesto, queste testimonianze arricchiscono in maniera sostanziale le nostre conoscenze sul divenire della lingua slovena nel lungo periodo che cade tra i Monumenti di Frisinga e la pubblicazione, nel 1550, del primo libro a stampa sloveno. Benché in realtà esse non abbiano svolto – per i loro contenuti così specifici come per la loro marginalità geografica – alcun ruolo nella formazione della lingua letteraria slovena, nondimeno esse costituiscono una prova della vitalità dello sloveno già in un’epoca tanto remota. Il quadro dei documenti manoscritti presenti nella provincia di Udine sarebbe però incompleto se non si facesse almeno un rapido cenno a uno dei suoi più importanti cimeli in assoluto, l’Evangeliario di S. Marco, conservato presso il già menzionato Museo di Cividale (ma alcune sue parti sono a Venezia e a Praga)
dal web








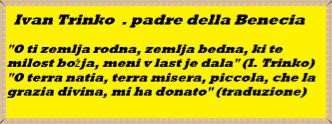
Felice Anno Nuovo!
RispondiElimina