il romanzo dello scrittore sloveno France Bevk sulla proibizione della lingua slovena nelle chiese dell’arcidiocesi di Udine, in italiano e a fumetti (con testo nel dialetto sloveno delle Valli del Natisone). La traduzione è di Ezio De Martin, le illustrazioni di Moreno Tomasetig e la prefazione dello scrittore Boris Pahor.La pubblicazione in italiano e la traduzione in fumetto del celebre romanzo dedicato alla drammatica situazione dei sacerdoti sloveni della Benecìa, è una scelta indovinata per far conoscere ad un pubblico più vasto il comportamento, per certi versi eroico, comunque di grande valore umano, da essi sostenuto per la difesa della dignità umana. Che questa si sia espressa nel campo specifico della fede cristiana, non fa altro che illuminare ulteriormente il valore di questa condotta.
Il romanzo ci offre uno spaccato preziosissimo della vita in una cappellania sulla sponda destra del Natisone, con il complesso intreccio di vita quotidiana, di celebrazioni liturgiche, di timori e paure, di persone coraggiose, di altre impaurite, opportuniste che sfruttano la situazione. In una parola, la vita concreta nella varietà delle sue forme, ma il tutto visto alla luce di quella dignità umana che dà sapore alle cose ed anche la forza di affrontare difficoltà non comuni. In una lunga carrellata passano in rassegna i protagonisti, che possiamo così elencare: il protagonista cappellano Martin, la sua collaboratrice domestica, la comunità ecclesiale, i vari rappresentanti della politica dal prefetto all’appuntato, i responsabili della Chiesa Udinese dal vescovo fino ai cappellani delle sperdute comunità montane, il tutto nella commistione di potere politico e religioso fra ipocrisia, astuzia, compromessi e silenzi.
 Il cappellano Martin, ricalcato artisticamente sulla figura di don Antonio Cuffolo, con qualche ritocco anche di don Giuseppe Cramaro, suo vicino di chiesa, è la figura dell’idealista che sposa la difficile realtà in cui si trova a vivere, convinto com’è della indivisibile unità tra Vangelo e dignità umana, espressa dalla esistenza concreta delle persone e della terra in cui vivono. È la linea della incarnazione, cioè di un inserimento dell’eterno e dell’invisibile nella nostra quotidianità, che non è mai banale per chi la vive con dignità. Martin vive per la sua gente e per il suo bene integrale, unendo due aspetti importanti della stessa realtà: le persone e la parola scritta, in questo caso il Catechismo. Non c’è crescita umana senza cultura e senza la sua immagine scritta; una parola che diventa documento e storia. Da ciò la difesa commovente dei libri sloveni, con l’aiuto della fedele collaboratrice. Non l’ideale falso di un popolo ignorante e fedele, ma quello di persone consapevoli e capaci di prendere posizione, perché coscienti di sé. Martin è il campanello che tiene desta la loro coscienza.
Il cappellano Martin, ricalcato artisticamente sulla figura di don Antonio Cuffolo, con qualche ritocco anche di don Giuseppe Cramaro, suo vicino di chiesa, è la figura dell’idealista che sposa la difficile realtà in cui si trova a vivere, convinto com’è della indivisibile unità tra Vangelo e dignità umana, espressa dalla esistenza concreta delle persone e della terra in cui vivono. È la linea della incarnazione, cioè di un inserimento dell’eterno e dell’invisibile nella nostra quotidianità, che non è mai banale per chi la vive con dignità. Martin vive per la sua gente e per il suo bene integrale, unendo due aspetti importanti della stessa realtà: le persone e la parola scritta, in questo caso il Catechismo. Non c’è crescita umana senza cultura e senza la sua immagine scritta; una parola che diventa documento e storia. Da ciò la difesa commovente dei libri sloveni, con l’aiuto della fedele collaboratrice. Non l’ideale falso di un popolo ignorante e fedele, ma quello di persone consapevoli e capaci di prendere posizione, perché coscienti di sé. Martin è il campanello che tiene desta la loro coscienza.Accanto a lui e con lui, la fedele collaboratrice, che si cura della casa, della chiesa e delle faccende quotidiane, ma anche di avvenimenti straordinari, come il salvataggio dei libri sloveni e la sopportazione degli scatti d’umore del cappellano. Il tutto vissuto nella discrezione, nel silenzio, tipico di un mondo che non c’è più e suggerito da un rispetto religioso, che dà un’aura quasi mistica a tutta l’esistenza. E con lei la comunità cristiana, quella che si riunisce in chiesa la domenica, nell’ascolto del Vangelo e della sua spiegazione. A questi cristiani, nell’agosto del 1933 viene tolta anche la possibilità di un nutrimento di cui ha doppiamente bisogno, come cristiani e come cittadini, portatori di una cultura millenaria, nello scrigno della lingua. Viene loro tolta la dignità della propria appartenenza nazionale e linguistica, che viene sganciata dalla professione di fede, quasi che si trattasse di due pezzi di un gioco d’incastro, interscambiabili a piacere. Questo popolo reagisce compostamente e con tristezza. Una reazione non violenta, silenziosa, che alla fine risulta anche vincente, perché non si assoggetta all’imposizione e attende, con il cappellano, una possibile liberazione.
Ci si aspetterebbe a questo punto, un intervento forte, deciso, sicuro da parte dell’autorità ecclesiastica. Nulla purtroppo, se non l’invito all’obbedienza ed allo studio della lingua italiana, in modo da realizzare quel programma politico che vuole tutto livellare, perché come ai tempi degli assolutismi, tutti parlino una sola lingua ed obbediscano ad un solo padrone. Non si chiede certo che il Vescovo si voti al martirio cruento, visti i momenti, ma che non abbandoni il suo gregge ed i pastori che lo aiutano. Una minima opposizione e resistenza da parte del Vescovo ci poteva essere, come testimoniano esempi luminosi di quegli anni, anche se rari, bisogna ammetterlo. E così, si ebbero esempi di cedimento da parte di qualche sacerdote, allettato dai vantaggi politici che questo comportava. E non sono mancate medaglie al merito contrario, per certi squallidi protagonisti, anche questi pochi, per fortuna, ma che potevano fregiarsi di qualche cavalierato di metallo scadente, sul piano dei valori umani.
L’apparato del regime fascista svolgeva il suo compito, alternando carota e bastone, per raggiungere il suo scopo di assimilazione forzata delle popolazioni della Slavia. Erano passati gli anni dell’impero asburgico, che un pluralismo culturale l’aveva sviluppato, e che permetteva ai diversi popoli di non perdere la propria identità. Queste cose, magari, furono scoperte dopo, visti i disastri del dopo. Certo che gli anni ’30 del secolo scorso, furono estremamente negativi per la Benecìa, tanto che i suoi effetti deleteri li sentiamo e viviamo ancora oggi. Hanno preso una piega subdola, che alla fine, continua l’opera devastatrice del fascismo. Infatti, è intervenuta la scoperta sensazionale che noi delle Valli, siamo di ascendenza slava. Un evento probabilmente unico nella storia dei popoli, ma che coltiva l’obiettivo della negazione. L’unica cosa che interessa è la cancellazione del sostantivo ed aggettivo ‘sloveno’. Ottenuto questo, tutto va bene, salvo lasciar perdere ciò che resta del dialetto sloveno, nei gorghi e nelle piene del Natisone.
E così la storia di Martin Čedermac continua, in tempi diversi, ma con gli stessi problemi, non di pressione politica, ma di contrapposizione pseudo linguistica. Alla fine resta paradigmatico il discorso finale del cappellano, una perorazione religiosa e civile, perché le due cose non vanno divise; una perorazione che invita ogni uomo – non più solo noi della Benecìa – a non svendere mai la sua identità, perché è l’unica carta della sua dignità e del valore assoluto della persona umana. Sempre e dovunque. (Marino Qualizza)








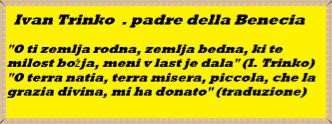
Ciao Olga! Il carattere del post è molto piccolo.
RispondiEliminaMolto curioso il cappellano MARTIN CEDERMAC.
RispondiEliminaAbbracci Olga.